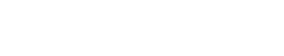Innovazione: gli effetti sul lavoro e performance delle imprese. La posizione dell'Italia nelle catene globali del valore
Scegli un argomento
Scenari industriali Confindustria n° 8 - Novembre 2017.
In sintesi
Da tempo il CSC osserva che è in atto un evidente rallentamento della velocità di integrazione dei sistemi economici. La globalizzazione è entrata in una fase di ripiegamento, anche a causa della crescente opposizione sociale e politica, soprattutto nei paesi avanzati, e proprio in quelli che prima l’avevano promossa quasi come un’ideologia.
L’interdipendenza internazionale dei sistemi economici rimane, però, molto alta. Per esempio, i flussi di IDE sono ancora il doppio di quelli registrati prima del boom dei Novanta e il loro stock addirittura triplo. E questo nonostante il dilagante protezionismo (soprattutto quello più insidioso perché erige barriere non tariffarie), il re-shoring e il puntare della Cina verso il mercato e le produzioni interne.
D’altra parte, ciò discende dal fatto che la struttura degli scambi internazionali di beni, come si è andata via via configurando, è sempre più stata condizionata da determinanti di ordine produttivo. Le catene del valore diventate globali modellano in misura importante la composizione e direzione degli scambi commerciali. Questi mantengono una forte inerzia, perché sono funzione dell’interazione strategica tra saperi manifatturieri sparsi in paesi diversi.
Molti di essi sono paesi in via di sviluppo. Non tutti, però. Infatti, negli ultimi venticinque anni il loro insieme si è bipartito. Da un lato le economie emergenti, che hanno saputo e voluto inserirsi all’interno delle catene di fornitura globali e ne hanno fatto la leva del loro sviluppo manifatturiero. Dall’altro i perdenti, quei paesi che non sono stati in grado di fare altrettanto e hanno ceduto ancora terreno.
Oggi si delinea un’ulteriore possibile linea di frattura nel mondo emergente. Per diverse ragioni. La prima è che la stessa globalizzazione forza verso la specializzazione, perché vincola il successo alla rapida acquisizione di un vantaggio comparato. Cosicché i ritardatari sono costretti a ricercarlo fin dall’inizio del loro processo di industrializzazione. L’effetto è quello di spingersi verso una concentrazione settoriale accelerata (anziché verso lo sviluppo di un ventaglio completo di produzioni) e potenzialmente verso una de-industrializzazione precoce.
La seconda ragione è nel fatto che le maggiori economie emergenti (Cina in testa) spiazzano le produzioni non solo delle economie avanzate ma anche quelle delle economie in ritardo, sia direttamente (conquistando i mercati senza lasciare spazi per altri attori) sia indirettamente (accaparrandosi la quota maggiore degli investimenti internazionali).
La terza ragione è che dentro le catene del valore si è molto evoluta la domanda che i clienti a valle rivolgono ai fornitori, cui è chiesto di realizzare un forte upgrading dell’offerta. Essendo le catene internazionali e i fornitori dislocati anche nelle economie in via di sviluppo, ciò comporta in quelle economie un nuovo gap tra chi riesce a tenere il passo e chi no.
In un mondo così globalizzato e integrato le esportazioni lorde non costituiscono più uno strumento di analisi adeguato della apertura e competitività dei singoli paesi. Le esportazioni misurate sulla base del valore aggiunto offrono una valutazione più precisa dello spessore e della forma delle catene globali del valore (GVC nell’acronimo inglese), perché indicano la componente di valore effettivamente contribuito da un paese.
Il primo effetto del cambio di metro è che la dinamica degli scambi così misurata risulta inferiore fino al 2008 ed è stata sostanzialmente uguale dopo il 2011. Ciò suggerisce che le GVC si siano espanse prima della crisi (inflazionando gli scambi lordi) e si siano sostanzialmente stabilizzate negli ultimi anni (almeno fino al 2014, ultimo anno per cui sono disponibili dati).
Nell’export in valore aggiunto l’Italia regge bene il confronto con gli altri paesi, tanto che le sue quote mondiali restano invariate. La buona performance del manifatturiero italiano è associata a una intensa e crescente partecipazione alle GVC, soprattutto a monte delle filiere, cioè come fornitore di semilavorati. La posizione italiana nella parte iniziale delle GVC è particolarmente evidente nei confronti della Germania, che è invece posizionata a valle, cioè più vicino agli acquirenti di beni finali. Secondo l’analisi del CSC la specializzazione a monte si è rivelata un vantaggio competitivo, perché ha permesso di trattenere dentro i confini nazionali le competenze e i miglioramenti qualitativi e tecnologici dei fornitori.
La crisi ha avuto cause e determinato conseguenze strutturali, coagulando una “nuova normalità”. Il suo esplodere aveva trovato, tra gli altri fattori che l’hanno provocata, un detonatore importante nell’insostenibile crescita dei consumi nei paesi avanzati (finanziati sempre più a debito) mentre avveniva un trasferimento massiccio di produzione e quindi di reddito in quelli emergenti. Il riaggiustamento della domanda interna (con il deleveraging del settore privato) ha ridimensionato i deficit commerciali dei primi e la domanda rivolta ai secondi.
Questo spinge a riequilibrare anche l’offerta del mondo emergente, ri-orientandola dai mercati esteri a quelli interni. È quanto persegue la Cina, dove decenni di basso aumento dei consumi a favore dell’accumulazione di capitale e delle esportazioni hanno lasciato il passo tra il 2006 e il 2015 all’abbassamento sia della propensione a esportare sia di quella a importare, con la sostituzione di input di importazione con input prodotti internamente.
Il comportamento dell’economia cinese appare, tuttavia, ancora isolato: le altre economie emergenti non hanno infatti ancora raggiunto un livello di industrializzazione paragonabile, che consenta loro di garantire la copertura di quote crescenti della domanda interna, che per giunta non è di dimensioni tali da consentire di alimentare l’offerta nazionale.
Dalla crisi il Mondo sta uscendo (il gerundio è d’obbligo, quando le politiche monetarie sono ancora da terapia intensiva), ma i ritmi della crescita di prodotto e commercio internazionale non sono quelli di prima. In realtà erano quelli ad essere stati straordinariamente elevati in una prospettiva storica e dunque da spiegare, mentre la velocità attuale è in linea con la media di lunghissimo periodo degli anni successivi alla prima rivoluzione industriale (fine ’700 - inizio ’800).
La domanda da porsi dovrebbe girare attorno ai fattori unici che l’hanno determinata: quale sarebbe stato il ritmo di sviluppo economico nel corso della seconda metà del Novecento senza la ricostruzione post-bellica, il baby boom, i massicci investimenti effettuati per creare le nuove metropoli, il ruolo dello Stato quale primattore e promotore, la fine della Guerra fredda, l’ingresso della Cina nel sistema economico internazionale? Nessuno può escludere che altri futuri eventi di carattere esogeno (attualmente non immaginabili) possano influire positivamente sul ritmo della crescita negli anni a venire, ma nessuno può neanche affermare che questo avverrà.
Ai fattori di cambiamento epocale descritti sopra si aggiungono gli sviluppi della tecnologia. L’impatto di quella digitale sulle imprese e sul mondo del lavoro, che in alcuni contesti è già realizzato ed è, soprattutto, in rapido divenire davanti ai nostri occhi (anche come diretti utilizzatori: smartphone insegna), si estenderà rapidamente in modo diffuso e profondo anche a settori che oggi sembrano lontani dall’epicentro del cambiamento.
Questa rivoluzione e le sue ricadute in termini di efficienza sono imperniate crucialmente sullo scambio di informazioni tra macchine e sull’evoluzione stessa della conoscenza in esse originalmente incorporata. In questo modo le macchine diventano capaci esse stesse di apprendere grazie all’interazione con l’ambiente nel quale operano (machine learning).
Le conseguenze sul lavoro saranno molto importanti. Realisticamente non sappiamo prevedere quale sarà l’effetto complessivo e a livello globale sull’occupazione, ma sappiamo con certezza che milioni di posti di lavoro saranno distrutti e creati nel mondo e che i nuovi posti di lavoro non necessariamente saranno negli stessi luoghi in cui sono stati perduti e sicuramente richiederanno competenze diverse da quelle attuali. Come è stato recentemente affermato, «Non importa quale lavoro e quali competenze una persona abbia, nessuno può essere realmente sicuro che il suo lavoro non sarà il prossimo» a essere colpito dalle nuove tecnologie e dalla globalizzazione.
Andiamo oggi incontro a una prospettiva di cambiamento della società che avrà una portata storica confrontabile con quella vissuta con la meccanizzazione dell’agricoltura e lo sviluppo della manifattura. Con un passo però incommensurabilmente più lesto. In quella fase storica i grandi paesi industriali hanno saputo accompagnare la transizione con un investimento senza precedenti nell’istruzione delle persone, con l’introduzione della scuola dell’obbligo e della formazione professionale. Quell’investimento è stato decisivo non solo nel fornire alla nascente manifattura lavoratori con competenze adeguate ma anche nel garantire la tenuta complessiva del sistema sociale.
Il grande sforzo formativo di quegli anni ha evitato che gli sconfitti dai cambiamenti tecnologici (contadini, piccoli proprietari agricoli, artigiani e operai esperti nelle tecniche divenute obsolete) andassero ad alimentare un esercito di persone ostili al cambiamento.
Uno sforzo analogo e perfino maggiore è richiesto oggi, perché la trasformazione in atto non è solo tecnologica ma ha una dimensione culturale che investe direttamente il ruolo degli imprenditori, delle politiche pubbliche e dei singoli lavoratori. Occorrono modelli formativi nuovi, che aiutino chi governa le imprese a comprendere la natura del cambiamento in atto e chi è chiamato a eseguire i nuovi compiti ad acquisire le competenze necessarie. Sapendo che le persone da coinvolgere, nel mondo avanzato, avranno sempre più un’età che irrigidisce e chiude all’apprendimento.
Per i sistemi industriali delle economie avanzate l’eredità più densa di implicazioni degli anni della grande globalizzazione e della crisi è la fenomenale e crescente divaricazione nei risultati delle imprese. L’aumento della concorrenza internazionale, il ridimensionamento della domanda interna in alcuni paesi (Italia anzitutto) e le nuove tecnologie hanno rappresentato shock che hanno innalzato l’asticella competitiva imponendo strategie aziendali più evolute. Ne sono uscite vincenti le imprese che disponevano delle risorse e delle competenze per attuare le nuove strategie e trasformare i radicali cambiamenti di contesto in opportunità di crescita. Per le altre è diventata maggiore la difficoltà di fronteggiare il mercato ed è più che mai cruciale, per farle evolvere, la disponibilità di beni pubblici idonei a consentire la costruzione di strategie di evoluzione emulative di quelle adottate dalle vincenti. La politica economica, in particolare industriale, torna così ad avere un ruolo determinante per mettere le imprese in condizione di competere in un mondo molto più complesso.
In questo mondo l’Italia industriale può e deve trovare uno spazio e una prospettiva di sviluppo nuovi. E deve anche riuscire a ridurre i divari di comportamento e di performance che ancora caratterizzano i suoi territori e le sue imprese.
L’analisi del CSC mostra, con metodo e interpretazione originali, che la direzione geografica dei cambiamenti nei territori del manifatturiero italiano ha mutato di segno. Per molti anni la diffusione delle attività produttive sui territori ha accompagnato l’espansione della base manifatturiera, con una direzione precisa: ha dapprima interessato le regioni del Nord Est e del Centro e poi si è gradualmente estesa al resto del versante adriatico fino al Mezzogiorno, tagliando fuori porzioni maggioritarie del Sud Ovest.
Negli ultimi anni all’espansione si è sostituito il ridimensionamento della manifattura, quanto meno in termini di base occupazionale. Ma le trasformazioni territoriali non sono cessate; a partire dall’inizio degli anni Duemila non hanno però più un profilo facilmente identificabile. Sia le variazioni assolute dell’occupazione sia quelle dei tassi di industrializzazione, calcolati anche includendo le attività di servizio connesse alla manifattura, mostrano che i diversi territori procedono in questa fase in ordine sparso.
Di certo è però chiaro che la loro principale determinante è ora la resilienza delle diverse aree. Resilienza che dipende da una molteplicità di fattori, presenti in grado diverso nei singoli luoghi, cosicché la variabilità dei comportamenti delle singole aree aumenta.
La contrazione della base manifatturiera non va in ogni caso intesa come un evento che porti all’ineludibile collasso dei territori. I luoghi della manifattura in Italia sono stati investiti da trasformazioni di fondo, che ne hanno cambiato in profondità la struttura produttiva. Nei grandi centri industriali del Paese (basti pensare alle tre grandi capitali industriali Genova Torino e Milano) all’erosione dell’industria ha corrisposto la transizione verso attività di servizio avanzate, il cui sviluppo ha progressivamente trasformato la stessa identità dei territori. È decisivo quanto ciascuno di essi sia in grado di fronteggiare il cambiamento facendo leva sulle proprie conoscenze.
Un’altra questione, accennata sopra, è che anche nel sistema produttivo italiano si è registrata negli anni della crisi un’amplificazione molto marcata dei divari di performance tra le imprese. Le imprese ottengono risultati economici diversi perché sono diverse le une dalle altre più che per il fatto che operano in contesti istituzionali e di mercato differenti.
Tra le differenze di contesto ci può essere la maggiore o minore difficoltà di riallocazione delle risorse dalle imprese meno efficienti a quelle più efficienti. Secondo l’interpretazione più in voga, anzi, è proprio la misallocazione delle risorse, dovuta a vari ostacoli e rigidità, la prima causa della peggiore produttività italiana. In realtà, il CSC, attraverso un’analisi basata sui dati di bilancio delle imprese, mette in dubbio tale tesi dominante.
Il confronto tra Francia, Germania, Italia e Spagna mostra che l’allocazione del lavoro tra imprese ha un impatto limitato sui differenziali di produttività tra questi paesi. La Germania risulta essere il paese con il livello più elevato di produttività del lavoro e, al contempo, anche quello con la minore efficienza allocativa. D’altra parte, la Spagna mostra livelli aggregati di produttività più bassi accompagnati da una elevata efficienza allocativa. In Italia si rilevano sia bassi livelli di produttività sia scarsa efficienza allocativa delle risorse. Inoltre, nel periodo 2011-15 l’aumento della produttività è dipeso da dinamiche interne alle imprese e non da modifiche nell’allocazione delle risorse.
Le implicazioni di politica economica dei risultati di questa analisi sono che la rimozione degli ostacoli esterni alle imprese, che sono alla base della cattiva allocazione delle risorse, va certamente perseguita ma non è determinante per ridurre il grado di eterogeneità nella produttività tra e dentro i paesi. Altrettanto e forse più importanti sono le azioni rivolte a migliorare la capacità delle imprese di aumentare il valore aggiunto.
Per il raggiungimento di questo obiettivo un ruolo cruciale hanno gli investimenti in innovazione tecnologica dei prodotti e dei processi. Con il contributo fondamentale dell’ISTAT, che ha prima costruito e poi messo a disposizione una base dati integrata e unica per ricchezza di informazioni, il CSC ha analizzato la complementarietà tra le diverse strategie d’innovazione e le altre scelte delle imprese.
Da questa analisi risulta, tra l’altro, che la propensione a innovare non è correlata alle scelte di governance. Lo è invece alla scelta dei canali di finanziamento: il ricorso all’autofinanziamento e al capitale proprio è maggiore per chi innova di più. Differenze di rilievo si riscontrano anche nell’adozione di tecnologie ICT abilitanti per Industria 4.0, più frequenti nelle imprese innovatrici rispetto alle non innovatrici.
L’analisi mostra anche che l’introduzione di innovazioni di prodotto e di processo porta nei tre anni successivi a una migliore performance in termini di fatturato, produttività e occupazione. Ma la scelta di innovare e l’adozione di incentivi monetari per i lavoratori, se perseguite congiuntamente, possono generare risultati inferiori a quelli ottenuti solo innovando.
L’obiettivo di massimizzare l’efficienza del lavoro per ottenere target di risultato prefissati può entrare in conflitto con l’esplorazione di nuovi paradigmi tecnologici, che come tali sono dirompenti e rischiosi, mentre l’interesse a conseguire i premi invita a ridurre la propensione al rischio e a comportamenti conservativi, che stiano dentro i limiti fissati dai piani di incentivo stessi.
Il report completo e le slide del convegno di presentazione sono disponibili ai seguenti link:
Non sei associato e ti servono informazioni?
ContattaciAzioni sul documento