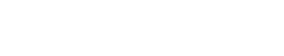I nuovi volti della globalizzazione. Alla radice delle diverse performance delle imprese
Scegli un argomento
Scenari industriali Confindustria n° 7 - Novembre 2016
In sintesi
Quali tendenze traccia la manifattura nel Mondo? L’Italia tiene il passo?
La globalizzazione non ha più il turbo: perché? E con quali prospettive per le produzioni italiane?
Cosa c’è alla radice dei divari di performance delle imprese? Si possono attenuare?
Attorno a queste tre grandi questioni ruotano gli Scenari industriali 2016. Questioni che sono tra loro concatenate e da tempo nei riflettori del CSC. Hanno importanti implicazioni di policy, anche associativa.
Anzitutto le tendenze. Che sono, da un lato, di rallentamento dell’ascesa degli emergenti, in termini di velocità di crescita del valore aggiunto manifatturiero, che comunque rimane elevata, e di consolidamento del primato cinese (28,6% la quota sul totale mondiale nel 2015, dal 22,8% nel 2012 e dal 6,8% nel 2000). E, dall’altro, di ripresa dell’attività industriale negli avanzati, soprattutto in USA e Germania.
L’Italia ancora arranca. Tuttavia, l’annuale classifica elaborata dal CSC evidenza che il Paese riesce a difendere la seconda posizione in Europa e si colloca settimo nel Mondo, con una quota del 2,3%, seppure quasi dimezzata rispetto al 2007. Invece, è nono nell’export di manufatti, ottavo se si mette in conto il recente deprezzamento della sterlina, che riduce il valore esterno delle merci britanniche.
Soprattutto, stanno cambiando a vista d’occhio le relazioni commerciali e quindi i legami produttivi degli emergenti con il resto del mondo.
La Cina si sta affrancando dall’approvvigionamento all’estero di beni intermedi, quindi contribuisce in modo forte all’accorciamento delle catene del valore. Inoltre, l’interscambio di semilavorati è sempre più
fitto tra gli emergenti stessi mentre cala quello con gli avanzati.
C’è, quindi, un ulteriore segnale di polarizzazione delle piattaforme industriali, che non è più solo geografica, ma tra paesi a diverso stadio di sviluppo.
Tutto questo contribuisce a spiegare perché il commercio internazionale cresca a un ritmo molto più basso che in passato e addirittura inferiore a quello del PIL globale, mentre fino a non molto tempo fa aumentava
a un passo più che doppio. È un cambiamento che il CSC ha colto già da qualche anno e che indebolisce un importante fattore di traino dell’export italiano, imponendo invece alle imprese di presidiare
da vicino i nuovi mercati.
Comunque, la domanda per il Made in Italy è forte e crescente. Il brand Italia mantiene integra la grande capacità di attrazione, che va meglio colta con la promozione internazionale declinata in tutti gli aspetti: promozione dell’export, intercettazione dei nuovi turismi, investimento nella e valorizzazione della cultura.
È su questo brand che occorre far leva per aiutare a colmare, là dove ancora possibile, i vuoti di produzione scavati dalla crisi. Vuoti molto differenziati tra settori (rispetto al picco pre-crisi si va dal -50% del legno al +11% del farmaceutico) e territori, con il Sud che ha subito i danni maggiori anche in termini di perdita di potenziale manifatturiero, già molto inferiore a quello del Nord.
Peraltro, il rilancio del sistema industriale italiano non può contare quanto altri su una massiccia presenza di multinazionali: lo stock di investimenti esteri è il 26% del PIL, contro il 60% della Spagna, il 43% della Francia e il 41% della Germania.
Inoltre, deve fare i conti con due ostacoli: la scarsa disponibilità di credito e la bassa profittabilità. Quest’ultima è in recupero rispetto ai minimi storici toccati nel 2012, ma rimane penalizzata da un costo del lavoro che sale (+24,6% tra 2007 e 2015) a ritmi quasi tripli di quelli della produttività (+9,5%).
La trasformazione più importante nello scenario e che è sempre meglio visibile riguarda il minore slancio della globalizzazione. E ha almeno tre aspetti: il già citato stop dell’ascesa degli scambi internazionali nell’organizzazione delle produzioni, la formazione di tre grandi aree industriali (Nord America, Asia ed Europa) e la differenziazione delle catene del valore.
In realtà, l’incidenza degli scambi cala per gli emergenti mentre continua a salire, seppure molto più lentamente che nell’ante-crisi, negli avanzati. Quali forze determinano questo cambiamento profondo?
Il CSC ne ha individuate cinque. Anzitutto, la normalizzazione della crescita cinese, con spostamento del baricentro dal manifatturiero ai servizi e dagli investimenti ai consumi, ossia da un percorso grande attivatore di scambi mondiali a uno che lo è molto meno; da sola essa spiega direttamente quasi un terzo della frenata degli scambi.
In secondo luogo c’è l’accorciamento delle catene del valore (o filiere) globali, che riflettono scelte politiche (la Cina punta a fare in casa quel che prima importava; gli avanzati rilanciano il ruolo dell’industria) e aziendali (una maggiore integrazione a monte e a valle1); le filiere globali, stando a una misura elaborata dall’OCSE, si sono ridotte dell’1,7% annuo dal 2011, mentre per un ventennio si erano espanse del 4,0%.
Poi c’è la caduta degli investimenti nelle economie avanzate (-2 punti percentuali in quota sul PIL), essendo i beni di investimento potenti movimentatori di import-export. Ancora, il ritorno del protezionismo, più o meno strisciante. E infine, la diminuzione del prezzo delle materie prime, che nei paesi esportatori netti di commodity ha tagliato le gambe all’import di beni.
Ma proprio quando la globalizzazione perde il turbo cresce l’avversione contro di essa, ritenuta responsabile dell’aumento delle sofferenze sociali. Ciò alimenta sentimenti di chiusura e anti-mercato.
Indubbiamente, la globalizzazione e le nuove tecnologie hanno innalzato l’asticella della competizione, generando opportunità e difficoltà, vincitori e vinti: tra le imprese (di cui si parla più avanti) e tra i lavoratori. Una divaricazione accentuata dalla crisi.
L’ascesa del nazionalismo (che è alimentato nei paesi avanzati anche dalla paura dell’immigrazione) è la reazione del corpo sociale, a fronte di una mancanza di risposte politiche adeguate, che dovrebbero puntare su una crescita solida, inclusiva e sostenibile. Una crescita incentrata sul manifatturiero e sull’innovazione e con un supporto, non solo economico, alle classi sociali medio-basse.
Anche in questa nuova, e perfino più sfidante, fase della globalizzazione l’Italia può giocare bene le sue carte. In particolare nelle produzioni più specializzate, che richiedono specifiche capacità e conoscenze e il saper rispondere rapidamente a variazioni della qualità e della quantità domandate, spesso su misura delle specifiche della clientela.
La questione più delicata, tra le tre elencate all’inizio, è quale sia l’origine della diversa performance delle imprese.
È la più delicata perché da essa dipende la capacità di reazione dei sistemi produttivi ai cambiamenti, a cominciare da quello appena evidenziato della globalizzazione e da quelli delle nuove tecnologie. E da essa dipende la tenuta e il rilancio del sistema produttivo e, conseguentemente, del tessuto sociale che ne fa da base e che ne riceve i benefici di occupazione e reddito.
È la più delicata perché richiede una particolare gestione nelle politiche, anche da parte dei sistemi di rappresentanza delle imprese, chiamati a rispondere a domande degli associati sempre più differenziate e a tenere insieme, in una stessa casa, soggetti che vivono risultati molto distanti.
La divaricazione delle performance era iniziata prima della crisi e si è accentuata con essa. Il CSC l’ha qui analizzata con tre tagli distinti: livello e dinamica della produttività, in un confronto europeo; diversificazione e unicità dei prodotti; innovazione.
Emergono due chiare risposte e una potenziale grave debolezza. La prima risposta è che la differenziazione di performance non è un’anomalia italiana ma è presente e persistente, con la stessa intensità anche se con qualche disomogeneità, in tutti i sistemi economici.
Le statistiche dicono che la produttività nelle imprese in testa per efficienza, misurata sul valore aggiunto per occupato, è più del doppio di quella nelle imprese in coda e il divario è salito nel corso della crisi: in Italia si è passati dal 120% nel 2007 al 155%, in Germania dal 105% al 148%, in Francia dal 148% al 172% e in Spagna dal 112% al 141%.
Ciò accade perché a qualunque latitudine le competenze di gestione, nell’ordinario ma soprattutto nello straordinario (ossia nelle strategie e nei loro cambi), non sono distribuite uniformemente tra quanti sono a capo delle imprese. In altre parole, come in ogni ambito umano, gli imprenditori non sono tutti uguali.
La seconda risposta discende da questa diversità originale: i saperi, che le imprese hanno accumulato nel corso del tempo e che continuano ad accumulare nell’imparare facendo, determinano le possibilità di scelta in ogni dato momento e, quindi, le capacità di reazione ai mutamenti del contesto. Non sono saperi legati esclusivamente alla sfera produttiva e alla tecnologia, ma a tutta la vita aziendale.
Saperi che sono sempre e comunque distintivi e collettivi, ossia dati dall’interazione tra le persone che danno vita all’impresa stessa. In ciò si potrebbe dire che non c’è un’impresa tale e quale all’altra.
Da queste conoscenze dipende la capacità di diversificare e di produrre beni esclusivi, ossia la complessità delle produzioni. Non è un caso se l’analisi mette in luce, come tratto ulteriore di eterogeneità, che il 65,4% delle imprese italiane è specializzato in un unico prodotto e appena lo 0,8% ne produce dieci tipi diversi.
Aiutare le imprese ad arricchire le competenze e ad accrescere la complessità aumenterebbe il benessere. Il CSC stima che un incremento del 10% della complessità innalzerebbe del 7,3% il PIL pro-capite. Perciò è una priorità che dovrebbe essere del Paese.
Tutto questo non vuol dire che chi, nella scala della performance imprenditoriale, sta sugli ultimi scalini non svolga ruoli importanti, anche nei confronti di chi si colloca sui primi. Se ne possono individuare almeno tre: mantenere e diffondere una cultura dell’intraprendenza e della difesa del ruolo centrale dell’impresa, come vivaio di imprenditorialità, esperienza di vita che genera emulazione; generare reddito e occupazione e, quindi, benessere e coesione sociale in quegli stessi luoghi in cui le imprese punte di diamante sono nate e si sono sviluppate, attingendo alle risorse che nei territori stanno; far parte delle filiere di quelle stesse imprese di punta, fornendo semilavorati e componenti, know-how, spesso artigianale (nel senso di adattabile alla bisogna), in competizione con altri e quindi a prezzi molto bassi (che trasferiscono valore all’impresa cliente).
Perciò è importante occuparsi di tutti gli imprenditori, anche in un’ottica di politica industriale, in modo da farne crescere (nei limiti del possibile) la consapevolezza che si può imparare dai leader e fornendo gli strumenti cognitivi per questo apprendimento. Al contempo facendo in modo che le imprese più avanti siano dotate dal Paese di tutti i supporti di cui godono i loro competitor internazionali.
Prendendo piena coscienza del fatto che l’esistenza naturale dell’eterogeneità comporta che applicare una medesima politica a soggetti diversi conduce a risultati molto diversi. E che lo sviluppo basato sui processi competitivi (in ogni campo sociale) conduce a divaricazioni, a quelle che sono state chiamate “grandi fughe”. Indispensabili per procedere nello sviluppo stesso.
Sta alla politica, poi, “portare tutti avanti”, senza inceppare quelle fughe: una missione che ne racchiude la quintessenza e che costituisce una grande impresa per il sistema della rappresentanza.
La debolezza che emerge dall’analisi del CSC sta nella risorsa principe e principale di ogni sistema economico, depositaria dei saperi: il capitale umano. È noto da tempo che l’Italia non ha, usando i metri e i test comuni, una ricca dotazione di capitale umano; all’opposto, spicca per la sua arretratezza e poco sta facendo per colmare il divario.
In passato questo divario era stato compensato dall’apprendimento sul lavoro, dalla voglia di fare e di emergere, dalla diffusa imprenditorialità, dalla trasmissione di saperi taciti legati alla materialità delle produzioni. Le nuove tecnologie e i nuovi mercati richiedono, invece, saperi codificati, cioè appresi a scuola
e all’università.
Anche le imprese che più delle altre innalzano la bandiera dell’innovazione (In hoc signo vinces) fanno poco ricorso ai laureati, rispetto ai loro competitor europei: in media sono meno del 10% della manodopera occupata. L’80% delle imprese italiane innovatrici si comportano così, contro meno del 40% in
Spagna e il 50% in Germania.
Sono dati che preoccupano, specie in vista della sfida dell’Industria 4.0. Che è una partita fondamentale per i destini del manifatturiero italiano, perché è la direzione verso cui sta evolvendo tutto il mondo industrializzato. Ma, per le ragioni appena dette, rischia di essere ulteriormente divisiva tra chi è in testa e chi è nelle retrovie della performance d’impresa.
Per evitare ciò e anzi per renderla un trampolino per la rincorsa e il ricompattamento, l’accompagnamento è cruciale e il Sistema Confindustria, con le sue ricche articolazioni territoriali e settoriali, è chiamato a giocare un ruolo chiave. Peraltro, alcune delle misure appena varate dal Governo vanno in questa direzione.
Negli ultimi anni Confindustria ha sottolineato la necessità di tornare a ideare e attuare una politica industriale in quanto strumento organico di politica economica, come avviene in tutti gli altri maggiori paesi industriali, avanzati e non. Con il duplice obiettivo di rilanciare la crescita e consentire alle imprese di agganciare i nuovi driver di sviluppo.
I driver originano dalla continua e intensa innovazione tecnologica, dall’evoluzione delle dinamiche demografiche, dall’urgenza di contrastare i cambiamenti climatici. Ovunque essi sono stati individuati nella sostenibilità ambientale, nella green economy, nella digitalizzazione, nel welfare e nella sanità, nella rigenerazione urbana, nella creatività che fa leva sul patrimonio culturale e nella sicurezza.
Attraggono in molti paesi enormi investimenti e generano nuovi posti di lavoro grazie alla combinazione positiva di diversi elementi che li caratterizzano: domanda globale in crescita, legata alla soddisfazione dei nuovi bisogni delle società avanzate in termini di sostenibilità, qualità della vita, sicurezza personale e collettiva, benessere psico-fisico; esternalità positive dell’attività di impresa, che giustificano un forte ruolo pubblico nella regolazione della domanda e nel sostegno dell’offerta; forte integrazione tra manifattura e servizi, secondo modelli di filiera allungata, spesso su basi internazionali; elevata componente innovativa con utilizzo consistente di tecnologie abilitanti e con alta potenzialità di trasferimento ad altri settori economici e produttivi; integrazione delle attività attraverso lo sviluppo delle reti energetiche e di telecomunicazione; elevata possibilità di replicare i servizi prodotti per potenziare la capacità
di esportazione.
Dunque, interpretare correttamente i driver consente di trasformarli in opportunità di business e di intercettare la nuova domanda di beni e servizi. Facendo leva sulla qualità e sull’adattabilità delle produzioni italiane.
Le imprese italiane più attente ai trend internazionali già si muovono in queste direzioni, che hanno ricadute trasversali su tutti i settori.
La nuova politica industriale può catalizzare e accelerare il movimento, delineando specifici indirizzi.
Anzitutto, potenziando il sistema per l’innovazione e il trasferimento tecnologico, che consenta di collegare i risultati della ricerca con le attività delle imprese e con la creazione di nuovi mercati. Perciò occorre un intervento pubblico coerente, dalla ricerca agli incentivi; che utilizzi la domanda pubblica e la regolamentazione tecnica; che valorizzi il contributo dei diversi livelli di governo. A cominciare da quello europeo: l’UE ha messo in campo 50 miliardi per progetti in questi driver e nell’innovazione.
Il Piano nazionale Industria 4.0, presentato dal Governo lo scorso settembre e concretizzato con gli incentivi inseriti nella Legge di stabilità, rientra in questo solco e testimonia la volontà di delineare una strategia complessiva di crescita del sistema produttivo e del Paese.
Una strategia che non guarda ai settori ma privilegia interventi trasversali e che supera la frammentarietà delle decisioni assumendo un impegno forte e centralizzato per la definizione delle linee d’azione e per il monitoraggio della loro attuazione.
È un primo importante passo verso la costruzione di una politica industriale che abbracci le diverse traiettorie di sviluppo del Paese, puntando su grandi progetti di trasformazione.
Siamo di fronte a un passaggio stretto. Alle imprese è richiesto di più, ma l’orizzonte dentro cui devono muoversi offre meno opportunità di prima, perché le prospettive di crescita globale si sono ridimensionate per tutti.
C’è da fare un salto, che è prima di tutto culturale e richiede per essere realizzato una qualità del capitale umano più alta. Ma l’esigenza di questo salto non trova tutte le imprese attrezzate nella stessa misura, in ragione della loro storia e delle loro specificità. Ne potrebbero derivare nuove forme di dualismo
(che già si stanno delineando).
Occorre che le istituzioni, anzitutto le associazioni della rappresentanza, che possono così svolgere un ruolo nuovo, creino le condizioni perché lo sviluppo coinvolga il maggior numero di attori possibile.
Il report completo e le slide del convegno di presentazione sono disponibili ai seguenti link:
Non sei associato e ti servono informazioni?
ContattaciAzioni sul documento